Appagante e dolorosa la vita di Susans Sontag (1933-2004). Nata a New York da famiglia ebrea, il padre morì di tubercolosi in Cina quando lei aveva cinque anni. La madre, con problemi di alcolismo, si risposa con un militare americano, Susan a diciassette anni sposa un professore di sociologia, a diciannove anni ha un figlio. Il matrimonio dura otto anni, nel frattempo Susan aveva scoperto la sua omosessualità. Muore di leucemia.
Provocatori fin dal titolo i suoi primi scritti, Contro l’interpretazione e Stili di volontà radicale. Ha poi scritto, oltre che saggi: romanzi, racconti, diari, testi teatrali, è stata regista cinematografica, in ogni caso un’intellettuale inquieta ed impegnata.

Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società
La fotografia viene vista da Sontag non solo nelle sue potenzialità documentarie ed artistiche ma pure, in una sorta di etica della visione, come ciò che ci interroga su ciò che val  la pena guardare e su ciò che abbiamo il diritto di osservare.
la pena guardare e su ciò che abbiamo il diritto di osservare.
La fotografia è una conoscenza vorace che trasforma il mondo in immagine e che ha il potere anche di manipolarlo. Staccandone dal flusso un’immagine, la rende preziosa testimonianza ma al tempo stesso le dona un valore simbolico che va oltre l’avvenimento stesso. Le fotografie sconvolgono fintanto che mostrano qualcosa di nuovo, e ci mettono in un ambiguo atteggiamento di curiosità quasi indifferente di fronte al dolore degli altri. In una sorta di effetto anestetico, possono far apparire normale l’orribile.
Malattia come metafora
“La malattia è il lato notturno della vita”, scrive Susan Sontag, che vuole tuttavia liberare la malattia dalle inutili e dannose sovrastrutture metaforiche che l’hanno confinata ed ancora la confinano nel recesso quasi di una inespiabile colpa. “La maniera più sana di essere malati – è quella più libera da pensieri metaforici”.
La tbc, il cancro, l’aids sono malattie che hanno recato con sé nell’immaginario collettivo l’icona della consunzione, dell’inesorabilità, della colpevole contagiosità. Di fronte ad esse inopinatamente la medicina, che vorrebbe ritenere che tutte le malattie si possono curare, ha messo in campo un linguaggio marziale, sia che serva a raccontare la possibilità di una vittoria sia l’inevitabilità di una sconfitta.
Occorrerebbe dire la verità ai pazienti e demistificare la malattia. Ed invece: “Dal momento che la morte è oggi ritenuta un evento oltraggiosamente insensato, la malattia che viene largamente considerata sinonimo di morte è sentita come qualcosa che bisogna nascondere”.
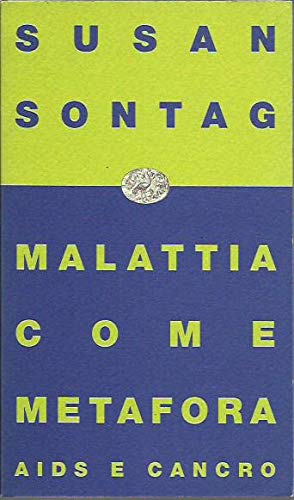 Anche la reazione psicologica delle malattie inguaribili è divenuta leggenda: il tubercolinico con la sua ansia di rubare sprazzi di vita e di bruciare prima di spegnersi; il malato di cancro debole e prostrato invece, svuotato da un’invasione, paralizzato e privato della sua vitalità. Come se i sintomi della tbc fossero ingannevoli, quelli del cancro sinceri. La tbc come malattia della povertà e/o dell’inquietudine, il cancro come malattia associata all’opulenza: l’una stimola l’appetito, l’altra lo fa perdere. La morte per tbc può essere edificante e raffinata, quella per cancro può essere clamorosamente orrenda. Nell’un caso accade come se lo spirito si sostituisse al corpo, nell’altro caso è il corpo che viene devastato, umiliato, mortificato. “Il cancro, potendo colpire ovunque, è una malattia del corpo. Lungi dal rivelare qualcosa di spirituale, rivela che il corpo è, sin troppo sciaguratamente, soltanto il corpo”. Quasi romantica, a confronto, la morte per tbc che “dissolveva la grossolanità del corpo, spiritualizzava la personalità, espandeva la consapevolezza”. Da una parte la sensualità e la passione che arde, dall’altra l’inibizione e la passione che avvizzisce.
Anche la reazione psicologica delle malattie inguaribili è divenuta leggenda: il tubercolinico con la sua ansia di rubare sprazzi di vita e di bruciare prima di spegnersi; il malato di cancro debole e prostrato invece, svuotato da un’invasione, paralizzato e privato della sua vitalità. Come se i sintomi della tbc fossero ingannevoli, quelli del cancro sinceri. La tbc come malattia della povertà e/o dell’inquietudine, il cancro come malattia associata all’opulenza: l’una stimola l’appetito, l’altra lo fa perdere. La morte per tbc può essere edificante e raffinata, quella per cancro può essere clamorosamente orrenda. Nell’un caso accade come se lo spirito si sostituisse al corpo, nell’altro caso è il corpo che viene devastato, umiliato, mortificato. “Il cancro, potendo colpire ovunque, è una malattia del corpo. Lungi dal rivelare qualcosa di spirituale, rivela che il corpo è, sin troppo sciaguratamente, soltanto il corpo”. Quasi romantica, a confronto, la morte per tbc che “dissolveva la grossolanità del corpo, spiritualizzava la personalità, espandeva la consapevolezza”. Da una parte la sensualità e la passione che arde, dall’altra l’inibizione e la passione che avvizzisce.
Nella mitologia romantica l’aspetto tubercolotico è indice di “una seducente vulnerabilità, una sensibilità superiore”. La tristezza interessante del malato, nonostante la realtà della malattia potesse essere molto più ripugnante. Il tubercolotico aveva le stimmate del carattere malinconico, una sorta di individualismo morboso che lo distingueva dagli altri.
“È il malato stesso a creare la propria malattia”: Sontag cita Groddeck, ma anche per criticare il senso di vergogna che viene perciò associato al cancro. “La concezione del cancro come malattia dell’incapacità di esprimersi condanna il malato di cancro: esprime pietà, ma trasmette anche disprezzo”. Quasi come se fosse la sanzione di un fallimento.
Le caratteristiche del cancro sono rispetto alla tbc un po’ quelle della depressione rispetto alla malinconia. “La poco romantica depressione ha soppiantato l’idea romantica di malinconia”. “La depressione è la malinconia senza le sue attrattive: l’animazione, gli scatti”.
In realtà l’approccio della Sontag è disincantato e demistificante: “Le teorie che vogliono le malattie causate da stati mentali e curabili con la forza della volontà sono sempre un segno di quanto poco si conosce degli aspetti fisici di un morbo”. Psicologizzare è un’operazione intellettualmente poco onesta, una sorta di spiritualismo sublimato. “L’interpretazione psicologica erode la realtà della malattia”. E fa ricadere sui pazienti la colpa della loro stessa malattia.
Nel caso del cancro più che mai il linguaggio bellico ha preso il sopravvento, nel descrivere l’invasione del morbo ma anche la virulenza della terapia, fino a giustificare la battuta spiritosa che la cura è peggio della malattia. Il malato di cancro è invaso da cellule aliene e mutanti. Il malato è posseduto da una forza estranea, ed i tumori sono, come le forze, maligni o benigni. Il cancro è l’emblema dei danni che l’uomo con l’industrializzazione ed il progresso tecnologico reca a se stesso, di come l’ambiente che l’uomo stesso ha creato lo renda meno duttile e spontaneo.
Ma, ancora demistifica la Sontag, il cancro non può essere considerato come malattia della civiltà industriale, poiché non è neanche una malattia specificatamente moderna. E la malattia non è innaturale, ma fa parte della natura quanto la salute.
Alla fine di un libro che è del 1978, Sontag può essere già facile profeta: “Man mano che il linguaggio terapeutico passerà dalle metafore militari di una guerra aggressiva a metafore imperniate sulle difese naturali del corpo… il cancro verrà in parte smitizzato”. “Allora sarà forse moralmente possibile, come non lo è adesso, usare il cancro come metafora”. Sperando forse invano che tale metafora non diventi obsoleta prima della soluzione dei problemi che in essa si rispecchiano.
Davanti al dolore degli altri
La fotografia, i media in generale, sono uno strumento che rende reale o forse iperreale il dolore degli altri a chi è privilegiato e non corre pericolo. Le immagini di guerra sono generiche, inducono sdegno senza peraltro invitare a schierarsi. “Per quanti” però “credono fermamente che il diritto stia da una parte e l’oppressione e l’ingiustizia dall’altra, e che la lotta debba continuare, ciò che conta è invece proprio chi viene ucciso e da chi”.
“La violenza rende chiunque le sia sottomesso una cosa”, scrive Simon Weil citata dalla Sontag. Nel 1924 venne pubblicato in Germania una galleria di fotografie orripilanti sulla violenza della guerra in un libro, di Ernst Friedrich, intitolato Guerra alla guerra. Testimonianza degli orrori della Grande Guerra, che pure fu salutata come “la guerra per porre fine a ogni guerra”.

“Assistere da spettatori a calamità che avvengono in un altro paese è una caratteristica ed essenziale esperienza moderna, risultato complessivo delle opportunità che da oltre un secolo e mezzo ci offrono quei turisti di professione altamente specializzati noti come giornalisti”. Noi “reagiamo con compassione, indignazione, curiosità o approvazione, man mano che ciascuna miseria ci si para dinanzi agli occhi”.
La realtà quasi deve tener dietro all’immagine che ce ne facciamo. “L’attentato al World Trade Center dell’11 settembre 2001 è stato descritto come irreale, surreale, simile a un film, in molte delle prime testimonianze fornite”. E d’altronde il significato di una fotografia trascende le intenzioni del fotografo. “La stessa fotografia contro la guerra può essere letta come un’immagine che mostra il pathos, o l’eroismo, l’ammirabile eroismo, di una lotta inevitabile che può concludersi soltanto con la vittoria o la sconfitta”. Ed in effetti nell’attuale scenario internazionale: “Eccezion fatta per l’Europa, che ha ormai rivendicato il diritto alla non belligeranza, resta vero che la maggior parte della gente non metterà in dubbio le giustificazioni addotte dal proprio governo per intraprendere o continuare una guerra”.
Nelle scene di violenza c’è qualcosa di osceno, quasi di pornografico. “La voglia di immagini che mostrano corpi sofferenti sembra essere forte quasi quanto il desiderio di immagini che mostrano corpi nudi”. Siamo tutti voyeur, in una morbosa mescolanza di shock e di vergogna. “Una scena orripilante ci invita a essere meri spettatori o vigliacchi, incapaci di guardare”.
C’è oggi una moderna sensibilità etica, basata sulla “certezza che la guerra sia un’aberrazione, seppure inarrestabile. E che la pace sia la norma, per quanto irraggiungibile”. E tuttavia nel corso della storia “la guerra è stata la norma e la pace l’eccezione”. Anzi, più di un movimento artistico si è fatto portatore di un’estetica della guerra. L’orizzonte invece cui conduce la riflessione della Sontag è se, a partire ed al di là della funzione di documentazione propria dell’immagine, sia possibile una pacifista estetica del silenzio, la possibile attenzione attraverso le scene di violenza ad un silenzio originario in cui tacciano le armi e le forze distruttive. “Quella che si definisce memoria collettiva non è affatto il risultato di un ricordo ma di un patto, per cui ci si accorda su ciò che è importante e su come sono andate le cose”.
 Le immagini da sole non bastano, occorre continuare ad interpretarle. “Le foto strazianti non perdono necessariamente la loro forza e il loro impatto. Ma non sono di grande aiuto, se il nostro compito è quello di capire. Una narrazione può farci capire. Le fotografie fanno qualcos’altro: ci ossessionano”.
Le immagini da sole non bastano, occorre continuare ad interpretarle. “Le foto strazianti non perdono necessariamente la loro forza e il loro impatto. Ma non sono di grande aiuto, se il nostro compito è quello di capire. Una narrazione può farci capire. Le fotografie fanno qualcos’altro: ci ossessionano”.
Il dolore degli altri – la Sontag fa riferimento a Bataille – può essere al tempo stesso estatico ed intollerabile. Sublime. “In quanto oggetti di contemplazione, le immagini di atrocità possono rispondere a bisogni diversi. Corazzano contro la debolezza. Rendono ancor più insensibili. Fanno accettare l’irrimediabile”
“La compassione ci proclama innocenti, oltre che impotenti”. Ma perciò può diventare, a dispetto delle migliori intenzioni, una reazione inopportuna, oltre cui dovremmo cercare di andare. Attraverso la memoria delle passate ingiustizie, ma soprattutto attraverso la comprensione di quelle attuali.
Senza poter frenare l’invasione di immagini propria dell’età moderna, è possibile un’ecologia delle immagini? Per la Sontag intanto temere che tutta la realtà sia spettacolarizzata è solo un vezzo di alcuni privilegiati, che possono pensare che non esista la reale sofferenza. “I cittadini della modernità, consumatori di violenza sotto forma di spettacolo, esperti della prossimità priva di rischi, imparano a guardare con cinismo alla possibilità di essere sinceri”.
Dove risiede dunque un’etica del moderno? “Possiamo distogliere lo sguardo, voltare pagina, cambiare canale, ma questo non vanifica i valore etico delle immagini da cui siamo assaliti”. “Tali immagini non possono che essere un invito a prestare attenzione, a riflettere, ad apprendere, ad analizzare le ragioni con cui le autorità costituite giustificano le sofferenze di massa”. “Se potessimo fare qualcosa per risolvere ciò che le immagini mostrano”: allora non saremmo solamente irretiti dalla loro subdola seduzione.
“Esiste un antidoto contro l’eterna seduzione esercitata dalla guerra?” Solo se noi capiamo cosa sia la guerra, solo allora i corpi martoriati dei soldati morti potrebbero, dall’immagine che li ritrae, avere interesse a cercare ed incontrare il nostro sguardo.







